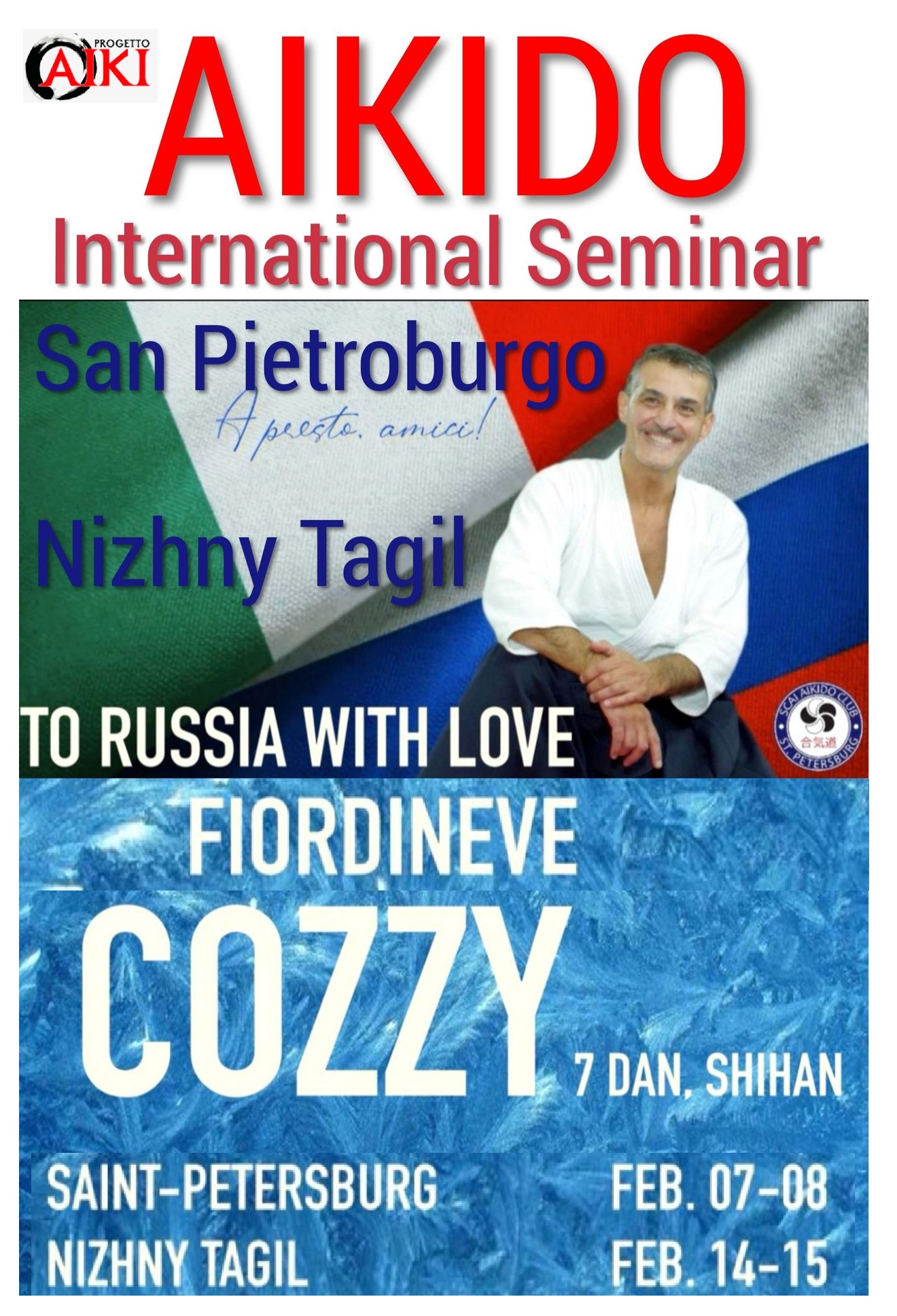Un tentativo di ragionamento partito dalla pratica del randori, proposto da alcuni che ne avvertono la rarefazione sia nella pratica quotidiana che durante gli esami, ma anche una attenuata intensità quando sia ancora richiesto. E lasciamo al lettore decidere se si avverte maggiormente la mancanza del randori o del ragionamento. Un ragionamento sotto forma di dialogo… un dialogo tra due insegnanti di lungo corso, che hanno avuto esperienze completamente diverse, anzi non hanno mai avuto modo di incontrarsi sul tatami. Eppure…
 Il randori è a discrezione dell’esaminatore (se parliamo di esami); ma visto che il compito di chi insegna è talvolta di tirare sassi in piccionaia, o nello stagno, tiriamo anche questo: non ha molto senso chiedere a un esame quello che i praticanti non hanno allenato regolarmente. E si vede quello che hanno fatto o non fatto, non c’è nemmeno bisogno di chiedere in giro. Ma per la verità esiste (esisteva?) anche durante la pratica quotidiana oltre che nei programmi d’esame, e sempre a discrezione dell’insegnante, il jiyuwaza: attacco libero, non conosciuto in anticipo.
Il randori è a discrezione dell’esaminatore (se parliamo di esami); ma visto che il compito di chi insegna è talvolta di tirare sassi in piccionaia, o nello stagno, tiriamo anche questo: non ha molto senso chiedere a un esame quello che i praticanti non hanno allenato regolarmente. E si vede quello che hanno fatto o non fatto, non c’è nemmeno bisogno di chiedere in giro. Ma per la verità esiste (esisteva?) anche durante la pratica quotidiana oltre che nei programmi d’esame, e sempre a discrezione dell’insegnante, il jiyuwaza: attacco libero, non conosciuto in anticipo.
É pur vero che il randori, in un esame ma non solo, può essere la modalità in cui si osserva la reazione ad una situazione di stress. Rappresenta parte di quello che l’insegnante non conosce del proprio discente. Lo può ipotizzare, preconizzare sulla base di altri indicatori ma capita che la reazione sorprenda chi è abituato ad osservare la messa in pratica della propria didattica per interposta persona.
Allora la domanda, a proposito della regolarità della sua pratica (del randori), potrebbe essere: è utile far diventare il randori una abitudine che smette, seppur in parte, di comunicare informazioni? La regolarità crea abitudini e, citando Seigo Yamaguchi Shihan, “per quanto buone abitudini, queste rimangono abitudini ancor più difficili da superare in quanto comunque buone”. Difficile il ruolo dell’insegnante…
I nostri maestri storici, tutti sanno chi sono inutile chiedere i nomi, dicevano che il giudizio lo potresti dare dopo aver visto come i candidati si mettono in seiza; quello che viene dopo è per loro, non per l’esaminatore: ma perché non si fa più randori, o se ne fa poco? Perché la preparazione della maggior parte dei praticanti non è sufficiente a poterglielo permettere: come dicevano i saggi dei tempi passati, vittoria o sconfitta si decidono molto, molto prima.
 Immagino che ognuno potrebbe dare la propria risposta originale (nel senso di autonoma… cosa che sembra essere l’esito di una mancanza di riflessioni comuni piuttosto che di una genialità più o meno incompresa). Ma la domanda non solo è legittima ma dovrebbe essere interna al processo attraverso il quale un insegnante trasmette un sapere. La rinuncia a porsi domande sull’oggetto della propria azione didattica poteva essere la condizione necessaria e sufficiente nell’era pionieristica della disciplina. La componente ludica, di fatto, bastava. Tanti i motivi. Dalla parte dell’insegnante ma anche dalla parte dei discenti. Molto è cambiato su questi due versanti. Non porsi il problema è il problema.
Immagino che ognuno potrebbe dare la propria risposta originale (nel senso di autonoma… cosa che sembra essere l’esito di una mancanza di riflessioni comuni piuttosto che di una genialità più o meno incompresa). Ma la domanda non solo è legittima ma dovrebbe essere interna al processo attraverso il quale un insegnante trasmette un sapere. La rinuncia a porsi domande sull’oggetto della propria azione didattica poteva essere la condizione necessaria e sufficiente nell’era pionieristica della disciplina. La componente ludica, di fatto, bastava. Tanti i motivi. Dalla parte dell’insegnante ma anche dalla parte dei discenti. Molto è cambiato su questi due versanti. Non porsi il problema è il problema.
Ma se scommettiamo sul fatto che questa assenza sia opera di una scelta consapevole, possiamo fornire elementi che la evidenzino o che indicano la necessità di una direzione opposta? Oppure esiste un problema di formazione didattica? Non sapere cosa far fare? In questo caso, ritengo, la consapevolezza sarebbe parte della soluzione. Porsi il problema degli obiettivi è, infine, lasciato ad un singolo o può/deve essere il frutto di una riflessione comune?
Mi rendo conto di aver spostato il punto di osservazione: da chi si deve impadronire di uno strumento (pericoloso, se si arriva a non poterne permettere l’uso), a chi lo strumento lo deve fornire, magari con il libretto di istruzioni allegato.
L’aikido è una disciplina che ha nel suo seno molto di artistico. Ma copiare non è arte. E’ il passo preliminare che prelude all’arte, E continuare a copiare alle soglie di quella porta, indebolisce, non fortifica. Il praticante che ha acquisito nel suo bagaglio la capacità di ripetere dei gesti tecnici, ma non è in grado di andare oltre accostandosi alla creatività, col tempo può indebolirsi inevitabilmente, sia per una sorta di assuefazione sia per il naturale degrado dovuto all’età.
Il randori pertanto non è stanca ripetizione di quanto si è visto in occasioni precedenti, ma anche se non soprattutto da parte degli uke, che si limitano troppo spesso a svolgere il loro compitino, che è fin troppo facile prevedere: ryokatadori. Ma non dilunghiamoci sulla tecnica.
Il randori, che è però soltanto uno dei tanti metodi di verifica, fa appello alla creatività del praticante, non alla sua capacità di assimilare e memorizzare situazioni standard; quella non è arte. Se non si è capaci di superare questa soglia non ci si riempia la bocca con l’abusato termine “arte marziale”
Non è un problema da prendere sottogamba: il praticante abituato ad assorbire senza fare appello alla propria creatività, senza la capacità di modificare le circostanze con cui si deve confrontare, può diventare interiormente debole. E porterà sul tatami i problemi della sua vita quotidiana, senza riuscire non diciamo a curarli ma nemmeno a dimenticarli, nemmeno per il tempo della pratica. Non sarà mai in grado di esportare, dal dojo alla vita “reale”, delle soluzioni o la capacità di trovarne e proporne, e se necessario imporne.
Concordo. Copiare non è interpretare. La pratica prevede il mettere in scena una situazione che rappresenta un conflitto. Una messa in scena finalizzata ad un obiettivo… Esattamente come una rappresentazione teatrale o la rappresentazione dell’ultima cena da parte di un pittore. Bene, esiste una differenza se la capacità interpretativa non è all’altezza del compito. Rendere credibile, possibile, quello che si interpreta. Essere capaci di sospendere la realtà per creare significato. Ed è questa capacità assimilata con le differenze, il talento, di ognuno che si può, a questo punto, esportare quanto si acquisisce in termini di incisività sulla propria vita quotidiana. Ma… lo studio? Quanto si deve disciplinare la proposta? Quanto spazio alla creatività viene lasciato al soldato macedone inquadrato nella falange o al soldato romano nella formazione a testuggine? Quale visione dell’arte in queste espressioni? Lascio a te una riflessione certamente più competente della mia ma conservo l’idea che anche in situazioni come quelle descritte ci sia spazio per una esecuzione che non sia copia.
 Fermo restando quanto asserito da Tada sensei durante un importante seminario: “L’insegnamento dell’aikido non è finalizzato alla formazione di persone in grado di eseguire ordini, ma al raggiungimento di una condizione in cui si sia in grado di darne, o perlomeno di prendere decisioni autonome”, si deve quindi considerare un fallimento il mancato superamento della soglia? No, sappiamo da sempre che l’arte non è accessibile a tutti. Ma l’artigianato è ugualmente nobile, prezioso, indispensabile. E forse più vicino alle necessità quotidiane di molti di noi.
Fermo restando quanto asserito da Tada sensei durante un importante seminario: “L’insegnamento dell’aikido non è finalizzato alla formazione di persone in grado di eseguire ordini, ma al raggiungimento di una condizione in cui si sia in grado di darne, o perlomeno di prendere decisioni autonome”, si deve quindi considerare un fallimento il mancato superamento della soglia? No, sappiamo da sempre che l’arte non è accessibile a tutti. Ma l’artigianato è ugualmente nobile, prezioso, indispensabile. E forse più vicino alle necessità quotidiane di molti di noi.
Nuovamente concordo. Un’orchestra ha bisogno di un direttore che esprime la sua capacità interpretativa di un’opera che nel suo essere determinata ha una caratteristica fondamentale. L’orchestrale esegue, artigianalmente, il proprio compito ma artigiano ed artista sono interni ad un Sistema di lemmi comune. L’arte sopravvive grazie ad entrambi e sostiene la fatica del quotidiano. Quello che a volte capita, sui tatami, che si voglia essere a tutti costi artisti non vedendo la forza dell’artigiano e accettarlo per se.
Ammettere che questa è la propria aspirazione e il proprio percorso permetterà, rinunciando consapevolmente a considerarsi artisti, di percorrere serenamente, e fino in fondo, la propria strada. Sul cammino dell’aikido.
Ottima conclusione e mi permetto di tornare all’insegnante: possiamo concordare che, in fin dei conti, l’azione didattica che pone degli obiettivi, è quella di favorire lo sviluppo di un ambiente che “estragga” le potenzialità dei discenti? “Educare” partendo dalla etimologia del termine? Artista o artigiano che sia non spetta a noi determinarlo. Se riteniamo di si, arriviamo, quindi, al punto in cui il lavoro dell’insegnante odierno oltre ad essere divulgazione si manifesti nell’agire da ricercatore che sperimenta, nel solco della tradizione, strade che possono rivelare conclusioni sorprendenti. Forse la crisi della disciplina, che molti denunciano, è una crisi di ricerca.
Nota: abbiamo voluto tralasciato di indicare chi dica cosa tra noi due. Lasciamo al lettore la – non ardua – soluzione del dilemma. Ammesso che abbia una qualche importanza, ma non saremo noi a giudicarlo.
Nino Dellisanti & Paolo Bottoni s.i.l.